Corsi in partenza:
Counseling filosofico / Educazione finanziaria
L'importanza della domanda giusta
Qual è la domanda giusta? Come facciamo a porla?
FORMAZIONE
Keren Ponzo
9/1/20254 min read
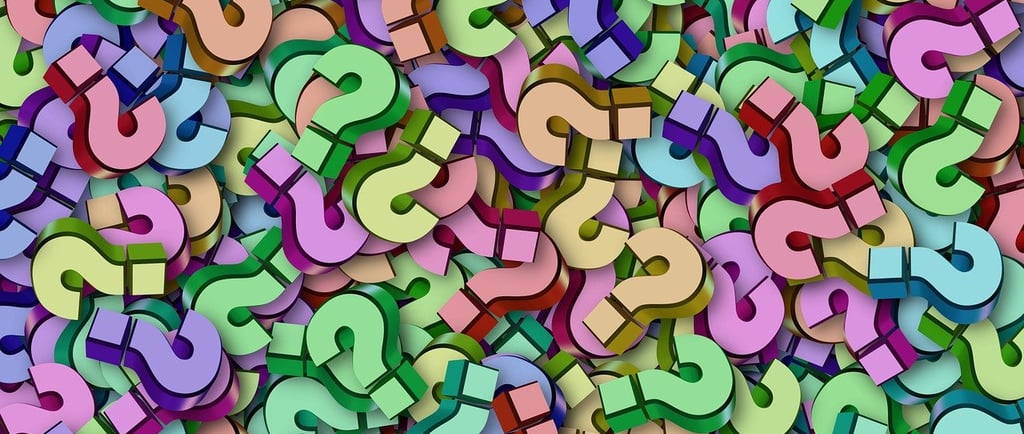
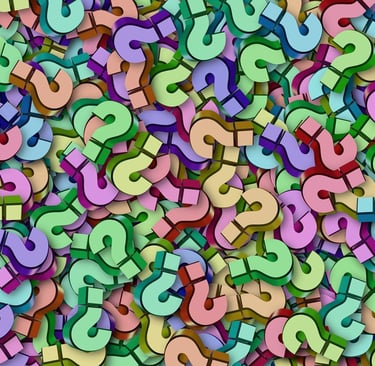
L’importanza di porre la domanda giusta
Non vi è gesto intellettuale più potente della formulazione di una domanda. Potremmo dire che l’atto stesso del pensare nasce quando una mente inquieta si rivolge al mondo, all’altro o a sé stessa chiedendo qualcosa. E tuttavia, non tutte le domande hanno lo stesso peso, né lo stesso valore. Esistono domande che aprono possibilità, altre che irrigidiscono e chiudono; vi sono domande che scalfiscono la superficie di un problema e domande che, come lame sottili, penetrano fino al suo nucleo. In questo senso, la vera posta in gioco non è semplicemente domandare, ma domandare bene, porre la domanda giusta.
La tradizione filosofica conosce bene questa esigenza. Già Socrate, nella sua instancabile attività maieutica, non trasmetteva dottrine ma esercitava l’arte del domandare. Il suo obiettivo non era ottenere una risposta definitiva, quanto piuttosto far emergere l’implicito, rendere visibili le contraddizioni interne al pensiero dell’interlocutore, condurlo a quella che chiamava aporia, cioè la percezione di non sapere davvero ciò che credeva di sapere (Platone, Apologia). Questo metodo si fondava su un principio semplice e radicale: la qualità del pensiero dipende dalla qualità delle domande che lo guidano.
Se trascuriamo questo principio, rischiamo di cadere nella trappola di una conoscenza apparente. Formulare domande banali produce risposte banali, domande guidate da pregiudizi producono conferme pregiudiziali. È la dinamica che conosciamo come “bias di conferma”: se la domanda è costruita per ottenere ciò che già sappiamo o vogliamo sapere, allora il processo cognitivo non è che un’illusione di ricerca. L’importanza della domanda giusta risiede invece nella sua capacità di rompere questo circuito, di scardinare i presupposti, di creare un vuoto fertile in cui la mente sia costretta a riorganizzarsi.
Domanda e verità
La filosofia occidentale ha a lungo collegato la ricerca della verità alla formulazione di buone domande. Heidegger, per esempio, sosteneva che “la domanda è la pietà del pensiero” (Essere e tempo), intendendo con ciò che il pensare autentico non si manifesta nella risposta, sempre provvisoria e situata, ma nell’apertura interrogativa che custodisce l’essere stesso delle cose. Porre la domanda giusta significa dunque dischiudere un orizzonte, un campo di possibilità che permette alla verità di mostrarsi. Non è un caso che in filosofia le risposte definitive siano rare, mentre l’arte del domandare abbia plasmato intere epoche del pensiero.
La domanda giusta non è soltanto un problema formale di linguaggio, ma un atto di responsabilità. Chiedere nel modo corretto implica l’assunzione di un rischio: quello di mettere in discussione le proprie certezze, di accettare risposte inattese, di entrare in una regione dell’esperienza che non avevamo previsto. È in questo senso che possiamo dire che una domanda ben posta è sempre un atto etico.
Domanda e scienza
Non solo la filosofia, ma anche la scienza è interamente costruita su questo fondamento. Ogni esperimento è in fondo una risposta a una domanda formulata in termini precisi. Il progresso della conoscenza non dipende tanto dalla quantità di dati raccolti, quanto dalla qualità delle questioni a cui quei dati sono chiamati a rispondere. Galileo, nel XVII secolo, non ha inventato soltanto strumenti di osservazione, ma ha saputo articolare domande nuove: non più “che cosa è questo fenomeno?”, ma “quali sono le leggi che lo governano?”. La rivoluzione scientifica non nacque da un accumulo di osservazioni, bensì dal mutamento della forma della domanda (Galileo, Il Saggiatore).
Da questo punto di vista, l’importanza di porre la domanda giusta è evidente nella prassi della ricerca contemporanea. Un esperimento mal progettato, basato su una domanda imprecisa o mal definita, genera risultati inutilizzabili. Una domanda lucida e radicale, invece, può aprire un intero campo di ricerca. Per questo, nella formazione scientifica, la capacità di problematizzare e di formulare ipotesi è più decisiva del possesso nozionistico.
Domanda e politica
Sul piano politico, la questione assume un rilievo particolare. Porre la domanda giusta significa anche saper spostare il terreno del dibattito. Chi controlla le domande, di fatto, controlla anche le risposte. Se la politica discute, per esempio, su “come rendere più efficiente il mercato del lavoro” e non su “quali sono i diritti del lavoro che vanno difesi”, già la formulazione della domanda incanala le possibili soluzioni entro una cornice prestabilita. In questo senso, l’arte della domanda non è mai neutrale, ma porta con sé un potere enorme di orientamento e di manipolazione (Chomsky, Media e potere).
La domanda giusta, in politica, non è necessariamente quella che ottiene consenso, ma quella che rende visibili i nodi nascosti, le contraddizioni che il discorso dominante tende a oscurare. È la domanda che interrompe la retorica, che obbliga a pensare l’impensato.
Domanda e vita quotidiana
Ma non bisogna limitare questa riflessione alla filosofia, alla scienza o alla politica. Nella vita quotidiana la capacità di porre la domanda giusta è ciò che distingue una conversazione superficiale da un incontro autentico. Quando chiediamo all’altro non semplicemente “come stai?”, ma “che cosa ti pesa in questo momento?”, oppure “che cosa desideri davvero?”, apriamo uno spazio di verità che altrimenti resterebbe nascosto. Le relazioni profonde si costruiscono sull’arte del domandare, non sulla moltiplicazione di parole.
Allo stesso modo, il dialogo interiore, quello che ciascuno intrattiene con sé stesso, si nutre di domande. Non vi è crescita personale senza la capacità di rivolgersi questioni difficili, di non accontentarsi di spiegazioni facili, di chiedere con onestà “chi sono?” e “che cosa sto cercando?”. In questo senso, la domanda giusta è ciò che impedisce alla vita di diventare inerzia.
L’enigma della domanda giusta
Resta tuttavia un enigma: come riconoscere che una domanda è quella giusta? Non vi è una regola universale. La giustezza di una domanda non è una proprietà astratta, ma una relazione tra il contesto, il problema e l’orizzonte che essa apre. Una domanda è giusta quando produce pensiero, quando smuove, quando disloca. Potremmo dire che è giusta quando non ci lascia come eravamo prima di formularla.
La domanda giusta, per sua natura, non può mai essere definitiva: se davvero è tale, porta con sé altre domande, genera un movimento che non si esaurisce. E forse è proprio questa la sua forza, l’energia che permette al pensiero, alla scienza, alla politica e alle relazioni di non cristallizzarsi.
Per concludere
L’importanza di porre la domanda giusta non è un dettaglio metodologico, ma il cuore stesso dell’attività umana. Le domande modellano la nostra conoscenza, orientano la nostra convivenza, determinano le nostre scelte individuali e collettive. Chi impara a domandare bene, impara in fondo a vivere in modo più vigile e consapevole. Non vi è libertà senza domande che rompano gli schemi, non vi è ricerca senza domande che aprano cammini, non vi è amore senza domande che tocchino la verità dell’altro. Per questo, porre la domanda giusta è forse la più alta delle arti: quella che non si esaurisce mai, perché sempre ci spinge oltre il già dato, verso ciò che ancora non sappiamo di poter pensare.
C.E.Fo.M. APS ETS
Counseling e pratiche filosofiche, formazione artistica, educazione permanente.
Risorse
Contatti
© 2025. All rights reserved.
C.E.Fo.M. APS ETS, C.F. 9015460242 / P.IVA 04063700241
Corsi
Associazione: presidente@cefom.it
Iscrizioni: iscrizioni@cefom.it
Info corsi: corsi@cefom.it